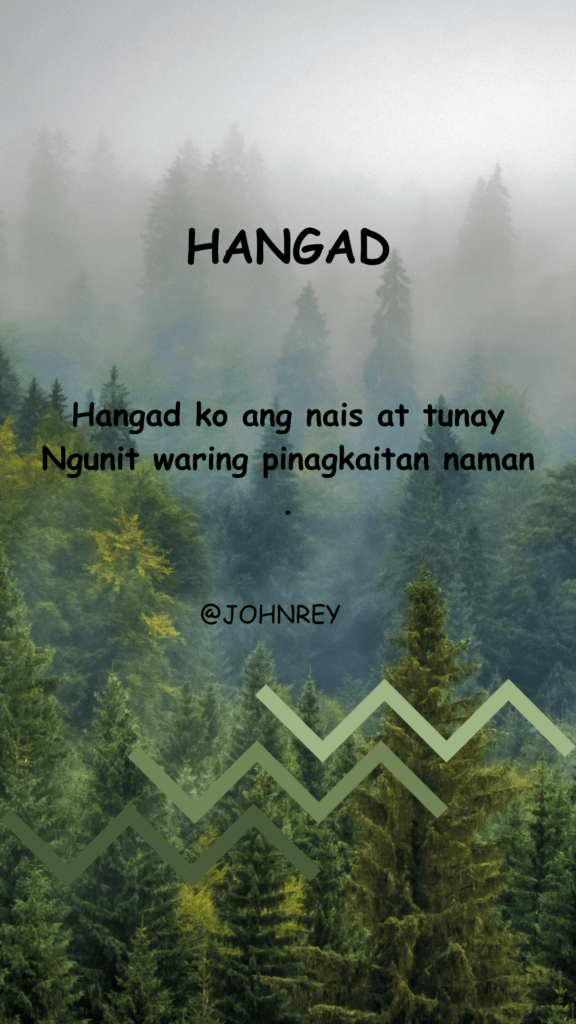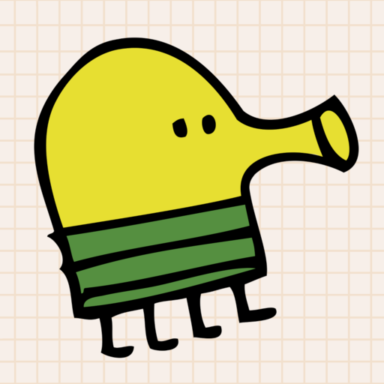Stando a quanto detto da una personalità vicina al Segretario Generale della Lega Araba, Nabil Arabi, emerge l’espressione, durante una riunione formale, della sua reale inquietudine a riguardo dei piani d’integrazione della Giordania e del Marocco all’interno del Consiglio di Cooperazione dei Paesi del Golfo (CCG). Egli suggerisce al proprio uditorio l’esistenza di un pericolo tangibile per la Lega Araba, poiché ne risulterebbe una nuova partizione del Mondo Arabo, con le monarchie e i principati da una parte, il resto dei paesi arabi dall’altra. Ciò permetterebbe all’Occidente di controllare efficacemente le fonti energetiche e l’insieme delle decisioni politiche riguardanti la regione.
Secondo la medesima fonte, il segretario generale aggiunto della Lega Araba, Ahmed Bin Houli (d’origine algerina) sarebbe perlopiù ridotto al ruolo di esecutore dei punti di vista e delle direttive del ministro degli affari Esteri del Qatar, lo sceicco Hamad Bin Jassem Bin Jabr Al Thani, il che ha portato numerosi partecipanti a porsi delle domande sulle reali posizioni dell’Algeria. Tanto più che, storicamente – e a comincare dal suo ministro degli affari Esteri Abdel Aziz Boutéflika, all’epoca in cui costui occupava questo ruolo – la diplomazia algerina si è sempre distinta per la sua fermezza e per l’efficacia delle sue iniziative all’interno della Lega. Avrà forse paura di subire la stessa sorte della Tunisia o della Libia, se non peggio?
Descrivendo l’offensiva dei paesi del Golfo, Nabil Arabi ha detto: “Un’offensiva di una tale forza e di tale ampiezza è molto inquietante” avendo, come prova, il fatto indiscutibile che alcuni di questi paesi si comportano come se la Lega Araba non fosse che una sorta di copertura che li autorizza ad attaccare altri Stati membri, come la Libia, lo Yemen, l’Egitto, la Siria etc… Come altri responsabili della Lega Araba, Nabil Arabi non ha potuto che constatare l’ambiguità che risulta dalle decisioni prese contro la Libia, e si è spinto a dire: “Personalmente, non sapevo che la decisione di stabilire una no-fly zone ed il divieto all’aviazione libica di volare potessero dare un pretesto alla NATO per andare a bombardare, con l’artiglieria pesante, le regioni libiche scelte come bersaglio. Se l’avessi saputo, non avrei mai permesso questa decisione”.
È sicuro che la legittimazione dell’intervento della NATO in Libia sia stata ordita sotto mandato di Amr Moussa. Da ciò la probabilità che Nabil Arabi abbia voluto inviare un messaggio chiarissimo per indicare che altri paesi arabi sono caduti nella stessa trappola; allo stesso tempo, in qualità di Segretario Generale della Lega Araba, Nabil Arabi ha dovuto finire per accogliere l’eliminazione di Muammar Geddhafi e del suo regime.
Inoltre, diverse fonti vicine ad Ahmed Bin Houli sostengono che Nabil Arabi abbia aggiunto che i paesi del Golfo hanno esercitato enormi pressioni per arrivare a far adottare la posizione di cui sappiamo contro la Libia, e che essi faranno presto lo stesso contro la Siria.
È doveroso ricordare che il testo dell’articolo, più che la decisione della Lega Araba, presa il 14 marzo 2011, sollecitava chiaramente il Consiglio di Sicurezza per un intervento militare in Libia, giacchè questo articolo chiedeva di “prendere immediatamente le misure necessarie per lo stabilimento di una zona d’esclusione aerea che impedisca ogni movimento dell’aviazione militare libica, stabilire una zona di sicurezza nei siti esposti ai bombardamenti fintanto che misure preventive non permetteranno la protezione del popolo libico e dei residenti di tutte le nazionalità, il tutto nel rispetto della pace regionale e della sovranità degli stati confinanti”.
Inoltre, diverse personalità vicine alla Lega Araba hanno affermato che attualmente alcuni paesi del Golfo, primo tra tutti il Qatar, fanno pressione per assicurare una copertura simile per legittimare un intervento internazionale in Siria, ma che hanno incontrato serie opposizioni da parte degli altri paesi arabi. Così, l’Egitto e l’Algeria hanno rifiutato finora di seguirli. Il Re dell’Arabia Saudita non si è più mostrato entusiasta, malgrado le pressioni provenienti da personalità saudite e kuwaitiane che non esprimono necessariamente la decisione ufficiale dei loro due paesi.
In questa situazione, si pongono delle domande riguardo alla complicità dei paesi del Golfo e di Ankara per destabilizzare la Siria dal suo interno.
I conoscitori degli arcani della Lega Araba si trasmettono informazioni sulle manipolazioni destinate a incoraggiare la Turchia e la Giordania ad elevare il livello della loro ingerenza negli affari siriani con il pretesto di proteggere i civili, i rifugiati, e i dissidenti dell’Armata, e ad incitarli a pensare seriamente alle modalità di stabilimento di “zone tampone” sui loro confini con la Siria. Tutto ciò accompagnato da una panoplia di sanzioni come il congelamento delle transizioni e degli affari finanziari nelle banche arabe, l’interruzione degli investimenti nei paesi del Golfo, la sospensisone della Siria dalla zona di libero scambio arabo (GAFTA), e la sua progressiva asfissia, dovuta alla pressione sugli stati e le società che trattano con i settori economici e finanziari siriani.
Ingerenza straniera e opposizione
Alcuni media israeliani, come il quotidiano “Haaretz”, si sono interessati ai diversi piani volti a trasformare Homs, Hama ed Edleb in “zone sotto la protezione internazionale”, ma i mezzi per ottenere ciò non sono stati trovati, dato che il doppio veto sino-russo pronunciato contro ogni intervento straniero negli affari siriani contribuisce sempre a rendere molto difficile questa manovra. Di conseguenza si stanno valutando altri mezzi, come l’idea dei “corridoi umanitari”, avanzata dal ministro degli Esteri francese Alain Juppé.
Conviene precisare che la Cina e la Russia non sono i soli paesi ad opporsi ai piani di destabilizzazione della Siria. In effetti, la proposta di un intervento turco o internazionale non ha ottenuto l’avallo di tutti i paesi membri della Lega Araba. Molti di questi hanno espresso chiaramente delle riserve, che ciononostante sono restate inascoltate o deliberatamente ignorate, come il disaccordo arabo-arabo riguardo all’opposizione siriana che chiedeva di essere rappresentata dal Consiglio Nazionale Siriano (CNS).
Secondo Ammar al-Qurabi (capo dell’Organizzazione nazionale dei diritti dell’Uomo, con base al Cairo –Ndt), Nabil Arabi avrebbe ricevuto venticinque richieste di colloquio da parte dell’opposizione siriana, nel momento stesso in cui il Qatar e alcuni paesi del Golfo, in particolare, stavano esercitando intense pressioni sui paesi arabi per portarli a riconoscere il CNS
Mentre altri paesi, perlopiù occidentali, considerano imperativo allargare la rappresentatività del CNS prima di riconoscerlo ufficialmente, altre forze dell’opposizione siriana dichiarano che il CNS non può rappresentare la volontà popolare. Essi accusano il CNS di essere dominato dalla Turchia, dal Qatar, e da altri paesi arabi, e di non essere altro che uno schermo dietro al quale si nascondono i Fratelli Musulmani. Ciò spiega perché il CNS non è stato ancora riconosciuto come l’unico rappresentante dell’opposizione siriana, né da alcuno Stato arabo, né da alcuno Stato occidentale.
Non è assolutamente da escludere che si stia ora assistendo ad una intensificazione delle pressioni che condurranno all’organizzazione di una conferenza che riunisca una “opposizione allargata” – dove verranno presentati tutti i partiti, o almeno la maggior parte – col solo obiettivo di legittimarne il riconoscimento da parte dei paesi arabi e occidentali e, al contempo, riuscire a delegittimare il governo siriano con tutto quel che ciò potrebbe generare ad ostacolo dei diplomatici siriani attenti alla politica estera, nei loro tentativi di conciliazione.
Bisogna sapere che il contrabbando di armi – che in diversi mesi hanno invaso il territorio siriano – ha provocato la divisione dell’opposizione siriana dall’esterno, e alcune personalità si rifiutano di dare credito al CNS. Così, Haytham Manna ha dichiarato con grande delicatezza nei confronti di Burhan Ghalioun: “Se le manifestazioni in Siria si fossero islamizzate, confessionalizzate, o armate, sarebbero già terminate”, dal momento che sono sempre le armi a stroncarle. Con il suo movimento d’opposizione, Manna ha sfidato Ghalioun e il CNS, che egli dirige, con la richiesta di adottare una posizione chiara in quanto alla separazione della religione e dello Stato.
Detto ciò, la maggior parte degli oppositori dicono che, se il regime siriano vuole evitare l’intervento straniero, sta a lui provare la sua volontà di promuovere riforme e dare il via a misure concrete in questo senso, soprattutto in termini di elezioni, permettendo una condivisione effettiva del potere.
Resta il fatto che, nelle ultime settimane, sia stato il Qatar a giocare il ruolo più importante per riunire gli oppositori.Del resto il Qatar ha invitato a Doha la maggior parte dei loro rappresentanti. Alcuni si spingono a dire che l’ultimo incontro del Primo Ministro qatariota con il principe ereditario d’Arabia Saudita sia stato dedicato quasi esclusivamente alla crisi siriana, dal momento che questi, dopo essere nominato, ha ricevuto un messaggio d’amicizia firmato dal Presidente Bachar el-Assad, al quale ha risposto con calore, augurando alla Siria di uscire sana e salva dalla crisi in corso.
Anche le autorità turche hanno svolto un ruolo di prim’ordine. Esse hanno intensificato le loro pressioni e le loro dichiarazioni intempestive, per voce di Recep Tayeb Erdogan. E, a detta di alcuni oppositori, uno tra tutti Al-Qurabi, è stata immaginata ogni sorta di scenario dalla direzione politica turca: “Colpo di stato militare, stabilimento di zone tampone, sanzioni economiche e finanziarie, e incoraggiamento alla dissidenza dei militari siriani”.
Inoltre, sembra che l’intervento dell’armata siriana a Homs, con l’adozione di una politica di sicurezza “chirurgica” che mirasse a catturare o a eliminare gruppi di bande armate, ha portato alcuni paesi del Golfo ad accelerare la cadenza e l’intensità delle pressioni sulla Lega Araba, e in particolare su Nabil Arabi, per stabilire un protocollo che ammanetti la Siria, in modo che non lo possa né accettare né rifiutare. Accettandolo, aprirebbe le porte ad osservatori non necessariamente neutrali, al traffico d’armi, alle manifestazioni, ai dissidenti armati. Rifiutandolo, aprirebbe la strada al Consiglio di Sicurezza e vanificherebbe l’azione della Russia.
Argomenti di disaccordo tra la Siria e la Lega Araba
Il quotidiano As-Safir è riuscito a procurarsi, da fonti vicine a Ahmed Bin Houli, dei documenti degli ultimi mesi che testimoniano gli scambi tra la Lega Araba e Damasco.
Il primo documento (n. 7435, del 16 ottobre 2011), prevede i seguenti punti:
1. Totale interruzione di tutti gli atti violenti diretti contro i cittadini siriani, e totale interruzione di tutte le violenze che da essi derivano.
2. L’annuncio delle autorità siriane della volontà di liberare tutti i prigionieri politici fatti per gli avvenimenti in corso, prima della celebrazione dell’Aid Al-Adha [festa del Sacrificio o AID AL-KEBIR, Ndt].
3. Totale evacuazione di ogni presenza militare nelle città e nei quartieri abitati.
4. Organizzazione di un Congresso per un vasto dialogo nazionale, nella sede del segretariato generale della Lega Araba e sotto la sua egida, entro 15 giorni, e dopo l’esecuzione dei già esposti articoli 1, 2, 3.
Questo congresso avrebbe dovuto riunire rappresentanti del governo siriano e di tutti i partiti dell’opposizione per accordarsi su una tabella di marcia che stabilisse le modalità necessarie per la costituzione di un processo di riforma politica conforme alle ambizioni del popolo siriano.
Il comitato ministeriale ed il segretariato generale della Lega Araba erano incaricati della preparazione delle modalità necessarie all’esecuzione di questi articoli.
Il 26 ottobre 2011, un secondo documento emanato dal comitato ministeriale “in seguito al suo accordo con Sua Eccellenza il Presidente Bachar el-Assad” precisava gli emendamenti seguenti, apportati dalla Siria:
1. Totale interruzione di tutte le violenze, qualunque ne sia l’origine.
2. Liberazione dei detenuti per gli avvenimenti in corso.
3. Totale evacuazione di ogni presenza armata nelle città e nei quartieri abitati.
4… non modificato.
5. Invito degli organismi ufficiali della Lega Araba e dei media arabi e internazionali a circolare liberamente in tutte le regioni siriane per informarsi e rendere conto della realtà di ciò che accade sul territorio.
Le informazioni provenienti dagli ambienti ufficiali della Lega Araba indicano che, a seguito delle discussioni che hanno avuto luogo a margine del consiglio ministeriale tra Nabil Arabi, i suoi consiglieri, e alcuni rappresentanti dei paesi del Golfo, lo sceicco Hamad in primis, l’impressione generale sia stata che la Siria rifiutasse queste soluzioni, come Nabil Arabi aveva sentito ripetere a più riprese dal Presidente Assad, e cioè che rifiutava qualunque attacco alla sovranità della Siria, e che il dialogo avrebbe dovuto avvenire in territorio siriano.
Ma l’approvazione siriana dell’iniziativa araba, abbinata al rafforzamento delle misure di sicurezza nelle regioni “calde”, in particolare durante l’AID Al-Adha, ha contribuito all’aumento del livello di pressione dei paesi del Golfo e dei paesi occidentali sulla Lega Araba, mentre i media arabi ed internazionali si concentravano a diffondere immagini di omicidi, violenze, incursioni, pretenziosamente attribuiti al regime siriano. A questo si è aggiunto il famoso “protocollo arabo”, il cui contenuto è stato sempre respinto, senza indugio, dai Siriani.
Le trappole del protocollo arabo
Ancora una volta, la Siria non ha risposto negativamente. Al contrario, ha deciso di andare in direzione del vento al rischio di trovarsi intrappolata nella burrasca. Ha accettato il principio del “protocollo”, lavorando al suo emendamento. Quindi, ha escluso l’articolo che trattava la presenza di “guardie personali o private”, ed ha rifiutato di sottoscrivere tutti i rapporti o i dispiegamenti di forze della Lega Araba prima di una consultazione incrociata con il governo, precisando che i rapporti dovranno essere presentati parallelamente al segretario generale della Lega e al governo siriano. In quanto ai finanziamenti, dovranno essere assunti a responsabilità della Lega Araba stessa.
Cosa porta la Siria ad accettare ciò che rischia di minacciare la sua sovranità?
L’opposizione vede in questo atteggiamento conciliatore del governo siriano un segno di debolezza che rivela la sua incapacità di rifiutare alcunchè, nemmeno ciò che annuncia la sua fine imminente. Il punto di vista dei dirigenti siriani è radicalmente opposto a questa analisi. Infatti, coloro che li appoggiano fanno notare che, dal momento che la crisi ha raggiunto il nono mese, non può essere sfuggito agli osservatori che il governo e l’esercito siriani sono rimasti solidali, che il numero di disertori non corrisponde alla proporzione osservata in tempi normali, che non ci sono particolari preoccupazioni sulla situazione finanziaria dal momento che la Siria sta uscendo da diciassette anni di blocco che non le hanno impedito di sviluppare la propria agricoltura e di esportare prodotti, e che la sua economia non potrà mai essere strangolata finchè le sue relazioni resteranno aperte con l’Iraq, il Libano, la Russia, l’Indonesia, l’India…
Le stesse persone considerano che questa attitudine conciliante da parte della Siria ha come risultato di mantenere l’”unità del fronte arabo” per evitare di legittimare un intervento straniero e rinforzare le posizioni della Russia e di altri alleati al Consiglio di Sicurezza. Tanto più che i Siriani possono presentare dei dossier documentati con foto, video e DVD che provano la partecipazione di centinaia di individui armati ad abusi, assassinii legati a differenzze comunitarie, mutilazioni di cadaveri, stupri… in particolare nella regione di Homs; alcuni di questi dossier confermano l’implicazione diretta di alcuni paesi del golfo nel finanziamento e nell’armamento, dossier che potrebbero essere divulgati se gli arabi persisteranno nell’intensificazione delle pressioni fino al punto di rottura.
Questa logica dei Siriani lascia pensare che non usciranno dalla Lega Araba. Ma, nel caso in cui alcuni li volessero escludere, essi ne dovranno sopportare le conseguenze. In questa sede non è inutile ricordare che Nabil Arabi ha raccontato recentemente di essere stato obbligato, quand’era Ministro degli Esteri, a rinviare la questione del riavvicinamento egizio-siriano, sotto pressione dei paesi del Golfo, come non è inutile ricordare che questa logica è sostenuta dal popolo siriano. In effetti, se le decisioni della Lega hanno trovato un’eco favorevole presso una parte dei Siriani, l’altra parte ha reagito con manifestazioni massive e ripetute. È così che le decisioni della Lega hanno messo in movimento le forze del patriottismo arabo in sostegno della Siria contro ogni intervento straniero.
In queste condizioni, sembra che la condizione siriana si diriga verso una sempre maggiore complessità, in quanto sul controllo della sicurezza interna interferisce l’immensa pressione dall’esterno. Ma alcuni, tra cui in particolare i Russi, sostengono che il regime è ancora capace di realizzare un’importante passo avanti in materia di riforme politiche, per le quali si dovrebbe accelerare il passo in modo da portarle alla realtà dei fatti. È ciò che ha condotto Mosca a giocare un ruolo di mediatrice e a ricevere una delegazione del CNS. Questa direzione segue alla “Conferenza d’Antalya”, che si proponeva di riunire i rappresentanti di tutti i partiti costituiti di oppositori siriani su base estera, e che si è concluso con un appello alla caduta del regime di Bachar el-Assad.
Recentemente, un certo numero di paesi arabi ha espresso la reale inquietudine nel caso di eventuali “passi falsi” contro la Siria. Ma è interessante notare che queste riserve sono state rifiutate da Nabil Arabi e dallo sceicco Hamed, e che gli emendamenti al “protocollo” proposti dall’Algeria non siano stati presi in considerazione. Alcuni suggeriscono che i tentativi per infiammare la situazione in Egitto siano in relazione diretta con altri dossier arabi e internazionali. Del resto la dichiarazione ufficiale dell’Egitto non rifletteva un grande entusiasmo, né per accogliere il CNS, né per un’intervento internazionale negli affari interni della Siria.
I pessimisti arrivano a credere che il Mondo arabo stia vivendo una tappa di disintegrazione della Lega Araba o la sua sottomissione ai diktat dei paesi del Golfo, che avrebbero bisogno dell’indebolimento del ruolo dell’Egitto, per cominciare.
Altri pensano che la battaglia regionale/internazionale abbia raggiunto il suo culmine fornendo un’occasione favorevole per attaccare la Siria come preludio all’accerchiamento dell’Iran. Ma questo supporrebbe che lo schieramento opposto, vale a dire l’Iran, la Siria, Hezbollah, la Russia, fossero pronti a uno scontro, in aggiunta alla complessità e alla durata della crisi siriana. A meno che non si verifichi un avvenimento interno inatteso, e che la situazione non degeneri in un conflitto con la Turchia, la Giordania, o…
Nel mezzo di tutte queste problematiche, il Libano dovrà probabilmente confrontarsi con una serie di sconvolgimenti della propria politica e sicurezza, poiché la maggior parte dei suoi politici definisce la propria politica in funzione della propria posizione sulla crisi siriana.
Sami Kleib
As –Safir, 25 novembre 2011.
Sami Kleib, giornalista libanese di nazionalità francese, è diplomato in Comunicazione, Filosofia del Linguaggio e del Discorso Politico. È stato direttore del giornale libanese As-Safir, a Parigi, e caporedattore del Giornale di RMC-Moyen Orient. Responsabile del programma “Visita speciale” su Al-Jazeera, ha dato le dimissioni per protesta contro il nuovo orientamento politico del canale televisivo.
Commento della traduttrice in francese
La guerra contro il popolo siriano non è di certo una “guerra dichiarata”, in quanto sprona l’opinione pubblica a interessarsi alla sua sorte in nome della pretesa “responsabilità di proteggere”, che sembra emergere come il mezzo ideale non per evitare la sua malriuscita, ma per fuorviare la nostra comprensione dei problemi reali. Poco importa che il popolo si mobiliti instancabilmente per mesi, per manifestare nella sua maggioranza il proprio sostegno al Presidente, lasciando da parte le richieste di riforme, divenute secondarie a fronte di un pericolo che l’ha messo a gran prova. Poco importa che esso rifiuti ogni ingerenza o intervento straniero, e che affermi il suo rifiuto di cedere all’escalation di violenza e agli squadroni della morte teleguidati e finanziati dall’estero. Poco importa la verità dei fatti a coloro che li snaturano, tanto che la nostra opinione pubblica continua a credere che il popolo siriano sia vittima dei suoi dirigenti, invece che obiettivo delle potenze straniere.
Ancora una volta la grande maggioranza dei giornalisti gioca sul conflitto tra il Bene e il Male. Le loro menzogne sono delle armi ben più dannose e soprattutto “umanamente” più accettabili di un intervento militare, reso momentaneamente impossibile per “ragioni tecniche” come ci spiega Sami Kleib; alcuni giornalisti che praticano contro il popolo siriano una strategia che potremmo qualificare come di “terrorismo mediatico”, con l’utilizzo di informazioni errate e non verificate, di video evidentemente modificati, e di reportage totalmente menzogneri. Ciò si è visto con la diffusione del reportage di Sofia Amara, che “Arte” e la “Television Suisse Romande” hanno diffuso e ridiffuso, malgrado il fatto che la sua mancanza di credibilità non sia potuta passare loro inosservata, tenendo conto delle proteste tempestive venute da persone direttamente coinvolte.
Ma qualcosa sta per cambiare. Sembra che non sia più assolutamente indispensabile consultare siti internet non infettati da manipolatori di ogni genere. In effetti, alcuni redattori dei nostri media “tradizionali” cominciano ad alzare un angolo del velo gettato sulle nostre coscienze, senza perlò rinunciare alla diffusione di informazioni false o tendenziose che provengono da fonti più che dubbie, come l’OSDH, il presunto “Osservatore Siriano dei Diritti dell’Uomo” con base a Londra, e che fa una relazione quotidiana di un numero di vittime, senza che si sappia nè chi ha contato i morti, nè la loro identità, nè soprattutto chi li ha uccisi.
Testimone di questo cambiamento? Un articolo edificante, apparso nel settimanale satirico “Le Canard enchainé” del 23 novembre, intitolato: “Une intervention “limitée” préparée par l’Otan en Syrie. En projet, una formation à la guérilla des déserteurs syriens par les services secrets français”! Gli estratti, qui ricopiati, la dicono lunga su questa invenzione dall’esterno:
[…]
“I Turchi propongono d’instaurare una zona d’”interdizione aerea” ed una zona tampone all’interno della Siria, destinata ad accogliere i civili che fuggono dalla repressione e i militari disertori (stimati a 8000, ufficiali superiori compresi, dai servizi informativi francesi). Non è facile da realizzare, poiché necessiterebbe che le basi aeree turche accogliessero gli aerei francesi e britannici”.
“Prima della realizzazione di questi progetti strategici, definiti dal ministero della Difesa, i servizi segreti hanno avuto molto da fare”. Nel Nord del Libano e in Turchia, dove si rifugiano molti disertori siriani, gli ufficiali francesi della DGSE e britanncisi di MI 6 hanno come missione la costituzione dei primi contingenti dell’Armata siriana libera, ancora embrionale”.
[…]
“Disertori da mobilitare.
Una guerra anti-Bachar come intermediario, dunque? “Non si tratta di ricominciare con ciò che è accaduto in Libia”, conferma un officiale d’alto rango alla Direzione dell’informazione militare. “Ma sono i Francesi e i Britannici che hanno preso i primi contatti con i ribelli”. Contatti politici, con gli esuli rifugiati a Parigi o a Londra, e militari, con i disertori, al fine di valutare l’importanza relativa della loro Armata siriana libera, che ha già attaccato numerosi edifici ufficiali”.
L’ASL, l’”Armata siriana libera”!? Non esiste questa armata che ha rivendicato l’uccisione di sette piloti militari siriani nell’autobus che li trasportava?
È necessario comprendere che è questa, vale a dire l’Armata siriana libera, che elimina i fiori all’occhiello dei “difensori della patria” (nome ufficiale dell’Armata siriana); è la stessa che la Lega Araba vorrebbe promuovere esigendo che il governo siriano allontani i soldati dell’Armata Nazionale dalle città e dai quartieri abitati? Un’Armata che ha già perduto più di mille soldati. In ogni caso è quel che sembra suggerire François Zimeray, Ambascatore francese per i diritti dell’Uomo e commilitone di Bernard-Henri Lévy, quando cerca disperatamente di convincerci, su “Europa 1”, “della dimensione della crudeltà della repressione siriana”. Non si perde più in dettagli per comunicarci le proprie fonti, ma gioca piuttosto su di una fibra sensibile di cui sembra egli stesso carente, tutto semplicemente perché non può ignorare chi commette queste crudeltà.
Infine è irragionevole considerare che il problema non sia “in” Siria ma sia “causato” dalla Siria, colpita dal fuoco di mire egemoniche contraddittorie e scettica sul mettersi in ginocchio, quando il suo popolo ha deciso di restare in piedi? E ci riuscirà? Osiamo crederci.
[1] Si veda il contro-documentario, in 8 parti, che mette gravemente in questione la credibilità del reportage: “Syrie, dans l’enfer de la répression”, realizzato da Sofia Amara, diffuso su Arte l’11 ottobre 2011. http://www.silviacattori.net/article2441.html
[2] http://www.mondialisation.ca/index.php ?context=va&aid=27865
[3] http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/11/24/97001-20111124FILWWW00663-syrie-7-pilotes-militaires-tues.php














 Armen Garinkovič Oganesjan (n. 1954, Mosca) è il direttore di “Meždunarodnaja Žizn'” (“Affari Internazionali”), rivista del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. Il direttore Oganesjan, esperto giornalista premiato con diversi riconoscimenti nazionali, è membro del Consiglio sulla Politica estera e la Difesa (organizzazione indipendente che opera a stretto contatto con gli organi parlamentari e governativi in funzione di consulente tecnico).
Armen Garinkovič Oganesjan (n. 1954, Mosca) è il direttore di “Meždunarodnaja Žizn'” (“Affari Internazionali”), rivista del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. Il direttore Oganesjan, esperto giornalista premiato con diversi riconoscimenti nazionali, è membro del Consiglio sulla Politica estera e la Difesa (organizzazione indipendente che opera a stretto contatto con gli organi parlamentari e governativi in funzione di consulente tecnico). Aleksandr Gelievič Dugin (n. 1962, Mosca) è professore presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Statale “M.V. Lomonosov” di Mosca, dove dirige il Centro per gli Studi sul Conservatorismo ed è responsabile del Dipartimento di Sociologia delle relazioni internazionali. Filosofo, si è però dedicato anche allo studio della geopolitica, realizzandone un manuale di ampia diffusione e servendo per anni da consulente della Presidenza della Duma di Stato della Federazione Russa.
Aleksandr Gelievič Dugin (n. 1962, Mosca) è professore presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Statale “M.V. Lomonosov” di Mosca, dove dirige il Centro per gli Studi sul Conservatorismo ed è responsabile del Dipartimento di Sociologia delle relazioni internazionali. Filosofo, si è però dedicato anche allo studio della geopolitica, realizzandone un manuale di ampia diffusione e servendo per anni da consulente della Presidenza della Duma di Stato della Federazione Russa. Vladimir Aleksandrovič Dergačёv (n. 1945, Transbaikalia) è fondatore e direttore d’un proprio Istituto di Geopolitica. Durante la sua carriera ha lavorato presso vari istituti, tra cui il Centro per l’Estremo Oriente dell’Accademia delle Scienze dell’URSS, ed è autore di circa 600 pubblicazioni scientifiche, tra le quali 40 libri, che lo rendono uno dei più prolifici ed importanti autori di geopolitica ucraini.
Vladimir Aleksandrovič Dergačёv (n. 1945, Transbaikalia) è fondatore e direttore d’un proprio Istituto di Geopolitica. Durante la sua carriera ha lavorato presso vari istituti, tra cui il Centro per l’Estremo Oriente dell’Accademia delle Scienze dell’URSS, ed è autore di circa 600 pubblicazioni scientifiche, tra le quali 40 libri, che lo rendono uno dei più prolifici ed importanti autori di geopolitica ucraini. per l’indipendenza senza compromessi. Aperture autonomiste, nonostante l’opposizione di Winston Churchill, furono elargite durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre nel corso della Grande Guerra la partecipazione di truppe indiane nei contingenti britannici non aveva portato alle concessioni che erano state promesse. Parallelamente, però, l’amministrazione inglese aveva esercitato il divide et impera per contrapporre la comunità indù a quella islamica, sicchè nel 1947 l’indipendenza venne ottenuta, ma il Pakistan, a maggioranza musulmana, si staccò dal resto del Paese (Partition) ed allontanò dal suo interno la componente indù. Nuova Delhi divenne pertanto la capitale dell’Unione Socialista Indiana, uno Stato federale che, pur nell’ambito di un sistema democratico, rimase fedele al sistema delle caste. Lo Stato imprenditore si fece carico di assorbire nella grande industria e nei servizi pubblici l’enorme massa di manodopera a disposizione e s’impegnò per debellare le zone di miseria e arretratezza specialmente in ambito agricolo, giungendo a garantire una qualità della vita in perenne aumento, costituendo la rete delle relazioni sociali e dei vincoli di casta un ulteriore prezioso ammortizzatore sociale. Il livello delle università e la diffusione di parchi industriali da cui ci si rivolge anche al mercato estero sono altri indicatori dei passi avanti che l’enorme nazione ha compiuto, ma causa l’eccessiva popolazione (siamo ormai attorno al miliardo e cento milioni di indiani) il PIL pro capite continua a rimanere basso.
per l’indipendenza senza compromessi. Aperture autonomiste, nonostante l’opposizione di Winston Churchill, furono elargite durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre nel corso della Grande Guerra la partecipazione di truppe indiane nei contingenti britannici non aveva portato alle concessioni che erano state promesse. Parallelamente, però, l’amministrazione inglese aveva esercitato il divide et impera per contrapporre la comunità indù a quella islamica, sicchè nel 1947 l’indipendenza venne ottenuta, ma il Pakistan, a maggioranza musulmana, si staccò dal resto del Paese (Partition) ed allontanò dal suo interno la componente indù. Nuova Delhi divenne pertanto la capitale dell’Unione Socialista Indiana, uno Stato federale che, pur nell’ambito di un sistema democratico, rimase fedele al sistema delle caste. Lo Stato imprenditore si fece carico di assorbire nella grande industria e nei servizi pubblici l’enorme massa di manodopera a disposizione e s’impegnò per debellare le zone di miseria e arretratezza specialmente in ambito agricolo, giungendo a garantire una qualità della vita in perenne aumento, costituendo la rete delle relazioni sociali e dei vincoli di casta un ulteriore prezioso ammortizzatore sociale. Il livello delle università e la diffusione di parchi industriali da cui ci si rivolge anche al mercato estero sono altri indicatori dei passi avanti che l’enorme nazione ha compiuto, ma causa l’eccessiva popolazione (siamo ormai attorno al miliardo e cento milioni di indiani) il PIL pro capite continua a rimanere basso.